Advaita-Vedanta
D. Per quale motivo nonostante qui si faccia spesso riferimento a Shankara, Gaudapada, Ramana Maharshi e Raphael, sembra che l'Advaita non venga trattato, mentre oggi l'Advaita va tanto di moda e ovunque ci sono incontri e corsi con Maestri Advaita, allievi di allievi di Nisargadatta Maharaji e Ramana Maharshi?
R. In Italia, rispetto ad altri luoghi, sono disponibili la maggior parte delle opere attribuite a Shankara. Pubblicate dall'Asram Vidya, molte hanno il commento di Raphael che, a sua volta, ha scritto parecchio sull'argomento e per anni è stato disponibile a chi ha fatto qualificata richiesta, anche dopo essersi ritirato dalla vita pubblica.
D. Ritiene che pertanto i libri siano sufficienti ad un approccio realizzativo?
R. I testi di Shankara sono molto chiari nell'indicare quali siano i requisiti di un aspirante discepolo alla tradizione metafisica universale. Quanti sono coloro che hanno questi requisiti? E quanti di costoro vengono qui?
D. Sta dicendo che rifiutate chi ritenete senza requisiti?
R. Qui non è facile stare, non offriamo plausi, non lusinghiamo alcuno, e cerchiamo di indirizzare ciascuno secondo i propri interessi. Se tali interessi possono essere meglio soddisfatti altrove, perché dovremmo privare costoro del meglio per loro?
D. In altri posti si parla di non realtà del mondo oggettivo, di facilità della realizzazione, di non necessità del maestro, fanno corsi, tengono convegni, etc.
R. Ah, comprendo, lei si sta riferendo a quanti narrano di essere discepoli di discepoli di qualcuno che hanno incontrato qualche volta o forse visto da lontano, e ovviamente non è più vivente da confermare tale discepolato e, ovviamente, fanno una vita del tutto differente da tali riferimenti, Nisargadatta e Ramana. Non si discute la buonafede di costoro, probabilmente c'è anche qualcuno che crede sinceramente nel mestiere che porta avanti. Tutti costoro però non risolvono una contraddizione in termini: se affermano che il Maestro non serve, perché trattano gli altri da allievi impartendo simili concetti? In ogni caso, che problema c'è? Proprio perché ci sono in giro tutte queste possibilità, è bene che qui rimangano quei pochi che aspirano a condividere un percorso tradizionale, nelle possibilità di condivisione di coloro che qui stanno portando avanti il dharma di dare luce all'integralità dell'insegnamento di certi Maestri.
D. Cosa intende con integralità dell'insegnamento?
R. Sembra essere diffusa la credenza che tutti siano pronti all'advaita vedanta, un via terminale, la fase più elevata, rarefatta, difficile del cammino spirituale, che necessita l'abbandono di ogni aspetto individuale, la focalizzazione e dissoluzione di ogni contenuto psichico, il totale scioglimento di ogni traccia di esso. Chi è disposto a ciò? Non certo chi è interessato a portare avanti una famiglia, a costituirla, a chi desidera gli affetti conseguenti all'amore, a chi è impegnato a costruire un futuro, a rimpiangere un passato, a crescere al meglio dei figli, a realizzarsi in un lavoro.
D. Mi sta dicendo che tutti costoro secondo lei sono esclusi dall'Advaita?
R. Secondo me? No, certamente. Tutti possono realizzare il Sé che già sono, ci mancherebbe. Ma occorre un requisito fondamentale: deve esserci una forte istanza realizzativa. Così forte da mettere tutto il resto in secondo piano. Se sono altre le priorità, saranno queste che verranno perseguite e una sadhana asparsa può solo che determinare problemi, non risoluzioni se le aspirazioni tendono altrove.
***
D. Quindi lei sostiene che coloro che insegnano l'Advaita Vedanta in realtà fanno perdere tempo?
R. A darle una risposta, sarebbe da chiedere "chi insegna cosa a chi". Ma è più semplice: "fintanto non si fanno male, dedicare del tempo allo studio, all'interiorizzazione e al silenzio, non può che fare bene".
D. Quale è il vostro scopo? Non è insegnare l'Advaita?
R. Qui ci vuole proprio: "Chi dovrebbe insegnare cosa a chi"? Osservi quella scritta, anche ove lei volesse vederlo e considerarlo possibile: "il magistero non va oltre questo limite, di additare cioè, la via e io viaggio; ma la visione è già tutta un'opera personale di colui che ha voluto contemplare". Noi siamo aspiranti e ove condividiamo l'aspirazione porgiamo anche la nostra testimonianza. Questo significa che chi ha altre priorità non è escluso dall'Advaita Vedanta, semplicemente può scegliere una via di supporto, uno yoga, sin quando non sarà pronto a non avere altre priorità se non la realizzazione del Sé, a percorrere la via senza supporto, l'asparsa vada, lo yoga dell'Advaita.
D. Perché c'è bisogno di altro e non si può praticare direttamente l'Advaita?
R. Perché non lo si può insegnare a chi non lo può praticare perché ha altri interessi; anche il più piccolo di questi interessi è più grande e pesante della rarefazione advaita, pertanto come conseguirla? D'altra parte la Bhagavadgita, parte importante del Vedanta, spiega i diversi modi di approccio al Divino, dei quali l'Advaita rappresenta solo la sommità. Posso solo consigliarle la versione dell'Asram Vidya tradotta da Raphael. Vede, nessuno necessita di realizzare la Non-dualità, Lei è già Quello, non c'è nulla da fare per essere sé stessi. Tutto il lavoro serve per smettere di credere di essere altro da sé.
***
D. Lei afferma che non occorre alcuno sforzo per realizzare il Sé.
R. Come può ciò che è l'Assoluto incausato essere determinato da altro? Esso non ha alcuna relazione con qualsiasi causa. Se lei chiude gli occhi, non sta cancellando il sole e quando li riapre non lo sta ricreando. Il sole è a prescindere da lei e da quello che lei può fare. Non deve fare nessuna fatica per vedere il sole, non è lei a crearlo. Ma se lei non ha alcuna intenzione di aprire gli occhi è chiaro che il sole non lo può vedere. Tutto lo "sforzo" è nel convincersi ad aprire gli occhi, ma se lei ha altro da immaginare, da sognare, etc. etc. ecco che prima di aprire gli occhi vorrà soddisfare i suoi desideri di altro. La realizzazione non duale del Sé, per come testimoniata dalla tradizione Advaita, è la stessa cosa. La dualità fa sì che nell'ente ci siano contrapposizioni, da un lato si desidera l'assolutezza del sommo bene, dall'altro si desiderano soddisfazioni circostanziali. È solo una questione di urgenza, di importanza, di potenza... il desiderio più urgente, più importante, più potente è quello che prevale.
D. Lei la fa facile. Non può essere così semplice!
R. Facile? No. Altrimenti tutti saremmo nel sahaja samadhi. Semplice? Sì. È semplicissimo. Sino a che l'essere incarnato necessita di fruire della propria molteplicità manifestata, l'ente si adopera per soddisfare il flusso causale che determina ciò. Una volta che prevale invece il mumukṣutva, l'intensa aspirazione ad affrancarsi da tutte le schiavitù, l'anelito alla liberazione, ecco che l'ente inizia a sforzarsi per staccarsi dagli ultimi contenuti, adesioni, sovrapposizioni. Ovviamente lei, avendo studiato i testi di Shankara, conosce le spiegazioni che gli ci ha lasciato in merito a... l'apertura degli occhi per vedere il sole. E' come certe mattine, o quando si è malati, quando gli occhi sono un po' cisposi e si deve faticare un po' per aprirli. Occorre qualche secondo, ma il sole è lì a prescindere da ogni sforzo, ma se non si sforza di certo non lo vedrà.
***
D. Le devo dire una cosa. Spero non si offenda. Trovo i suoi libri difficili. Perché? È lo stesso con i libri di Raphael. Quando leggo Balsekar è tutto più facile e mi esalto. Perché c'è questa differenza?
R. Forse perché Balsekar forse è un Maestro, mentre Raphael presta voce a determinati esseri quali Shankara e Platone?
D. Va bene, me la sono cercata. E lei?
R. Il sottoscritto non fa testo. È del tutto irrilevante in certi panorami. Sono un semplice portatore di acqua; che ogni tanto viene chiamato a fare l'autista quando c'è qualcuno in visita. Ma torniamo a Raphael. Non conosco Balsekar, ma immagino che le parole di Raphael siano semplicemente accessibili a chi è pronto ad esse, per evitare che qualcuno inavvertitamente si possa far male o possa portare nocumento ad altri. La mente si impadronisce facilmente di tutto ciò cui viene in contatto, osserviamo come le religioni in passato, e ancor oggi, vengano usate per uccidere e sterminare chi non condivide il medesimo punto di vista. L' "Ama il prossimo tuo come te stesso" è divenuto una spada che ha ucciso milioni di persone per "salvarne" le anime; con la scusa del "Dio unico" si sono sterminate popolazioni colpevoli di adorare il Dio unico con altre vesti e nomi. A cosa giungerebbe allora la mente dell'uomo se si impadronisse della non dualità? Sterminerebbe ancora più persone perché tanto "nessuno nasce e nessuno muore" ed è "tutta una illusione"? Già l'Advaita è frainteso da tanti che seguono gli pseudo maestri del "tutto è facile" perché sei già Quello, ci mancherebbe solo che spuntino come funghi a millantare di essere discepoli di Raphael perché ne hanno letto un libro o lo hanno incontrato una volta. Oggi va tanto di moda dire di essersi realizzati alla presenza di qualcuno...
Premadharma, tratto da forum pitagorico, luglio 2015

Caratteristiche del jivanmukti.
Sruti e Smriti affermano l’esistenza dello stato di Jivanmukti. La Kathopanishad dice: “Colui che è liberato è completamente liberato”, che significa che colui che è diventato completamente libero dalla schiavitù nel corso della vita, è libero anche da ogni possibilità futura di ricadere in schiavitù, dopo la dipartita dal corpo.Poiché se dopo la morte tutti rimangono liberi per un certo periodo di tempo, ma certamente rinascono in seguito, colui che ha ottenuto la liberazione in vita rimane libero dalla nascita per sempre. Nella Brhadaranyaka Upanishad è scritto: “quando tutti i desideri che albergano nel cuore sono svaniti, il mortale diventa immortale e consegue il Brahman già in questo corpo” (4.4.7).
In un altro passo della Sruti è detto: “Sebbene possieda occhi, egli è come se fosse privo di occhi; sebbene possieda orecchi, è come se non possedesse orecchi; sebbene dotato di mente, è come se fosse privo di mente; e sebbene dotato di vita, è come uno che non abbia vita”.
Il Jivanmukta è descritto con vari nomi, quali: Sthitaprajna (uomo dalla ferma saggezza), Bhagavad-bhakta (devoto di Dio), Gunaatita (al di là dei tre Guna), Brahmana (che ha realizzato il Sé), Ativarnaasramin (oltre i limiti dei Varna e degli Ashrama).
La condizione di Jivanmukti può essere ottenuta solo da una persona che abbia abbandonato tutte le azioni, quelle vediche come quelle secolari, che sia concentrato solo sulla conoscenza e immerso nella contemplazione del Sé. Jivanmukti e Videhamukti si distinguono solo in base alla presenza o assenza del corpo e degli organi di senso. In entrambi è assente la percezione della dualità.
Il Jivanmukta è colui per il quale questo mondo, in cui si muove e agisce, ha cessato di esistere. La mente della persona ordinaria reagisce alle varie forme del mondo e conosce la varietà e le differenze tra esse. La mente del Jivanmukta non viene modificata allo stesso modo e non percepisce differenze, ma vede tutte le forme come Brahman. Nel sonno profondo la mente non subisce trasformazioni, ma permangono in essa i semi della trasformazione. Perciò lo stato di sonno non può essere equiparato allo stato di Jivanmukti. I Jivanmukta non è toccato da piacere e dolore; non è compiaciuto per un fatto positivo, né è depresso per una calamità. Non brama di ottenere qualcosa, ma sopravvive con ciò che gli arriva spontaneamente. Sebbene i suoi sensi siano in funzione e possa fare esperienza di tutto, la sua mente è del tutto calma e non reagisce mai. Sebbene i suoi occhi vedano le cose, egli non le giudica buone o cattive, favorevoli o sfavorevoli, e dunque è libero da agitazione, attaccamento o avversione. I sensi, di per sé stessi, non causano alcun danno. E’ la mente che giudica ciò che viene esperito dai sensi e sviluppa attrazione e repulsione nelle persone comuni. Poiché la mente del Jivanmukti non sviluppa alcun giudizio, egli è privo di attaccamenti e di avversioni. Grazie all’assenza di agitazione mentale, egli è libero dalle vasana (impressioni latenti). La sua mente si mantiene sempre pura. Mai guarderà se steso come l’agente delle azioni, non identificandosi con il complesso corpo-mente, che è il vero protagonista dell’agire. Di conseguenza non è mai gratificato o depresso a causa dei risultati, buoni o attivi, delle azioni. Nessuno ha ragione di temerlo, poiché mai insulterà o offenderà altri in alcun modo. E mai avrà paura di altri. Rimarrà inalterato anche se insultato o aggredito. Egli non distingue le persone tra amici e nemici. Sebbene sia ricco di conoscenze, mai ne farà esibizione. La sua mente è del tutto esente da pensieri mondani e sempre concentrata sul Sé. Rimarrà sempre calmo, anche su fatti che lo riguardino direttamente, poiché libero da preoccupazioni di sorta, e soltanto consapevole della pienezza del Sé. Queste sono le caratteristiche del Jivanmukti.
Videhamukti.
Quando il corpo del Jivanmukta muore, egli diventa Videhamukta, liberato dall’esperienza empirica e realizzato nella sua vera natura, come l’aria ritrova quiete alla fine della tempesta di vento. Immediatamente è dissolto il suo corpo sottile. Non si può definirlo “sat” (vero, esistente), perché si dovrebbe esprimere, non si può definirlo “praajna” (unità soggetto-oggetto), condizionata dall’avidya, o “Isavara”, che è condizionato da Maya.
Non si può chiamare “asat” (inesistente, falso) o fatto di mera materia. Egli non sperimenta gli oggetti grossolani percepiti dai sensi. Non è Virat (il mondo), non Hiranyagarbha (uovo cosmico), non Isvara. Non è Visva (stato di veglia), Taijasa (sogno) o Prājna (sonno profondo). Perciò non si colloca nelle categorie di microcosmo (vyashti) o macrocosmo (samashti).
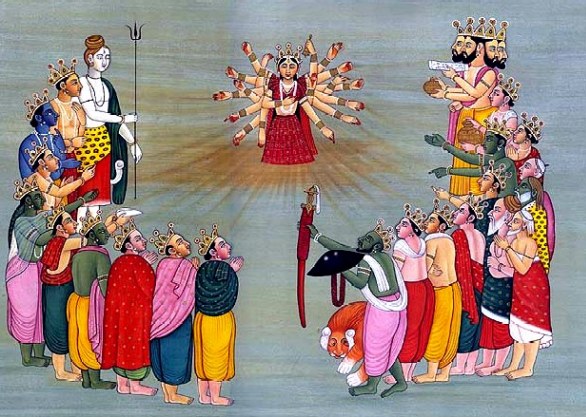
Brano tratto da: Vidyāranya, La liberazione in vita (Jīvanmuktiviveka), a cura di Roberto Donatoni, Adelphi, Milano, 1995
Il contemplare ti conduce all’Essere, mentre l’agire ti lascia nel divenire: la Conoscenza si svela solo nell’Essere e non nel divenire nel quale viene occultata. Seguire una Via di Conoscenza vuol dire inoltrarsi per un cammino profondamente contemplativo fatto di prese di coscienza e non di proiezione-attività.
La contemplazione non consiste nel proiettare un oggetto, una forma, un’immagine-simbolo, ecc. e nel “guardare” verso il proiettato: questa sarebbe una semplice “creazione” mentale, immersa nell’indefinito di māyā e soggetta alle sue leggi; in questo modo non faresti altro che consolidare quel rapporto duale soggetto-oggetto che invece intendi risolvere.
Per immergerti nella contemplazione devi unirti al contemplato superando la barriera formale e fonderti con esso a livello di coscienza. La contemplazione si attua quando il flusso della consapevolezza, reso continuo e ininterrotto, costante ed intenso, risolve la dualità e il soggetto si fonde con l’oggetto al di là dell’individualità e della forma.
L’autentica contemplazione (samādhi) è lo stato di coscienza in cui si verifica la fusione-identità essenziale del contemplante con il contemplato. Per contemplare è necessario portarsi prima nel silenzio mentale, nella non-attività del pensiero, quindi nella sua cessazione definitiva. Ogni proiezione è bandita o messa da parte se generata dall’inerzia mentale. Nell’immobilità la mente cessa di esistere come tale e al suo posto si svela la Consapevolezza sempre presente di là da soggetto e oggetto, ma che puoi attingere fondendo l’uno con l’altro. Contemplare è porsi in questa Consapevolezza, riposando in Essa e risolvendosi in Essa, immergendo tutto in Essa per gradi fino al totale autoassorbimento. Contemplare è guardare con la coscienza penetrando oltre la forma e risolvendo la stessa sostanza (Essere qualificato, saguna) nella pura Essenza priva di dualità (Essere inqualificato, nirguna). Contemplare è stabilirsi nella Consapevolezza che comprende il soggetto e l’oggetto e, reintegrandoli, li trascende, risolvendo ogni rapporto e contrapposizione conoscitiva e ogni relatività nell’assolutezza della Coscienza omnipervadente.
La contemplazione non è uno stato passivo o di quiescenza, ma un essere attivo e profondamente risolvente; l’azione, al contrario, è passiva, poiché nasce da un seme-immagine, si produce attraverso la soddisfazione di una tensione-desiderio e crea, a sua volta, una nuova impressione-tendenza che ti costringerà ancora, reiterando il ciclo in modo diverso solo in apparenza. L’azione si compie nel tempo-spazio, nella relazione, sotto la legge della necessità, cioè nel divenire; la Conoscenza è sempre, ovunque, indipendente da tutto, perché è Essere. L’azione è un anello della catena di causa-effetto, la Conoscenza il maglio che spezza ogni catena imprigionante. Agisci e ti incatenerai inesorabilmente, conosci e ti libererai.
Un oggetto, una condizione, una situazione contingente sono frutto di azione identificata. La Conoscenza non è frutto di nulla perché, essendo autoesistente, basta a se stessa. Dice Śaṅkara (Upadeśasāhasrī: 2.1.22): « La Conoscenza è di natura affatto distinta dall’azione, sia perché questa viene compiuta attraverso una quantità di mezzi sia perché i frutti che essa genera risultano adeguati [a tali mezzi] ».
Una causa finita, limitata e relativa non può avere come effetto l’Infinito, l’Illimitato o l’Assoluto. La conoscenza di Quello non è effetto di nulla, perché qualsiasi cosa, in rapporto a Quello, non-è. La Conoscenza è autoesistente, ma appare velata da sovrapposizioni fatte dalla sua stessa sostanzialità. Risolvi queste in Quella, rimuovi i riflessi relativi e mutevoli e realizzerai l’Assoluto immutabile. Conosci e sarai Colui che è.
Dalla contemplazione così come ti è stata insegnata scaturisce il riconoscimento diretto della Realtà ma, se non sei ancora pronto per contemplare la Realtà direttamente, puoi avvalerti della meditazione, la quale ti ci condurrà in modo graduale. Meditare su una cosa significa porre la cosa nel campo della consapevolezza; collocarla nel fuoco della visione, al centro, illuminata, distinta, isolata, senza altre presenze; far vibrare questa entità-immagine-suono conferendole energia-coscienza, sino alla sua autonomia; osservarla, avvicinarla, compenetrarla, infine fondersi con essa sino a che, a completa trasformazione, non resti che il solo flusso della consapevolezza di là dalla forma e dalla differenziazione. Meditare su dati, eventi, oggetti – tutti enti irreali – ti farà comprendere la loro irrealtà ma, anche, la realtà della tua Consapevolezza. Meditare sul Reale ti porterà rapidamente a immergerti nella Realtà. La meditazione – come dice Rāmana Maharshi – essendo consapevolezza, è la nostra autentica natura.
Come hai compreso, meditare è osservare coscientemente. La corretta meditazione, praticata per giorni, mesi o anni, ti porterà certamente alla contemplazione diretta, quindi alla Consapevolezza autoesistente. Dalla meditazione alla contemplazione, alla consapevolezza, all’Essere: grazie alla meditazione ti svelerai Ciò che sei.
Meditare significa rendersi consapevoli. Meditare su un oggetto, un dato, ecc. vuol dire suscitare in noi la consapevolezza dell’oggetto, ecc. Meditare è intensificare il flusso della consapevolezza sino a penetrare l’essenza dell’oggetto, del dato e così via per poi tralasciarli isolando la consapevolezza in sé. In verità, la meditazione dello jñāni è senza oggetto e senza soggetto: è la contemplazione pura quale Consapevolezza autonoma e continua, senza contenuti né riferimenti. È l’obiettivo che ti devi porre, l’epilogo della tua ascesa coscienziale. Per raggiungerlo, ricorda che solo nell’effettiva consapevolezza puoi realizzare una meditazione intelligente e realmente risolvente.
Meditazione, contemplazione, osservazione non si distinguono più per lo jñåni, ossia per chi ha risolto tutto, anche se stesso, in jñāna. Meditare, contemplare, osservare sono divenuti in lui pura Consapevolezza attuale, ossia puro Essere.

Tratto da:
Vidya Periodico Mensile - Dir. Resp. Paola Melis
Redazione: Via Azone 20, 00165 Roma - Tel&Fax 06 6628868
Copyright © 1973-2008 Vidya. Tutti i diritti sono riservati. Questo testo può essere riprodotto non a scopo commerciale, senza alcuna modifica e nella sua interezza, includendo queste notizie sul Copyright.
R - Ci sono molti modi per gustare la polpa che la noce di cocco nasconde entro la sua scorza coriacea. La posizione nella sādhanā può essere duplice: duale o non-duale. Nella posizione Advaita o Non-duale, nulla si contrappone alla pura Realtà, se non l’adesione all’apparente movimento-manifestazione della stessa individuazione di sé; si procede all’Assoluto, inizialmente con la discriminazione e il distacco, e, poi, senza alcun sostegno. Nella posizione Dvaita o Duale essendo di fronte due enti: l’Essere Supremo e la Manifestazione di cui l’uomo è parte, si pone la sādhanā come avvicinamento a tale Essere-Creatore. Della prima posizione abbiamo già parlato e, comunque, sarà oggetto di studi più approfonditi in futuro; parliamo della seconda, visto che a troppi piace criticarla. Sbucciare una banana è facile, ma se nel passato vostra madre non vi avesse insegnato che, a certa frutta, la buccia va tolta, voi, la prima banana, l’avreste assalita a morsi. Nel morso, dopo il primo sapore sgradevole, avreste sentito la dolcezza. Nella noce di cocco, purtroppo, non è così. Avete voglia a prenderla a morsi, l’involucro è coriaceo e, se anche non vi stancate, quando arrivate al guscio, non ci sono denti che tengano! La sādhanā duale è quella di chi vuole, a tutti i costi, gustare quella noce di cocco. Mentre, nella sådhanå advaita, noi siamo la noce di cocco e occorre semplicemente svelare gli involucri; nella sådhanå dvaita, il punto di partenza è distaccato dalla noce, essa è di fronte a noi e va aperta.
D - Sempre di noce si tratta, comunque. Cosa c’entra questo con il servizio e la devozione?
R - Il servizio - nell’azione senza frutti - e la devozione vogliono aprire la stessa noce di cocco che vedono distinta da sé. Il devoto-sevak prende la noce e la strofina su ogni superficie dura e ruvida che trova, egli sa che la noce che ha in mano è l’io, quindi cerca altri io su cui consumare la propria noce. Il devoto-bhakta si mette davanti alla noce e inizia a blandirla, a dargli piccoli colpetti, a parlarle, a chiedere di fargli il favore di aprirsi; la porta sempre in giro con sé, pregando l’Ideale divino di aprirsi; nel far questo spesso agisce come il devoto-sevak. Il devoto-jñānin, invece, prende una grossa lama e ripulisce pian piano la scorza dell’io, quando arriva alla noce va dall’Ideale divino, il Sé o Ātman, Gli porge la lama e chiede gentilmente di aprirla per lui. Il devoto-asparsin non vede né buccia né guscio di noce, si vede già come polpa e al limite può decidere di mangiarla con altri. L’identificazione, nei primi tre casi, fa sì che ognuno creda che il proprio, sia l’unico metodo per aprire la noce. Il devoto-sevak ritiene stupido parlare alla noce, pregarla o salmodiare i mantra, ritiene inutile anche prendere il coltello, poi, il vedersi già polpa gli sembra a dir poco assurdo. Il devoto-bhakta sa che il primo è un mezzo per preparare la noce all’apertura, ma vuole nel contempo parlarle, ringraziarla, quindi afferma che sì può funzionare, ma che lui preferisce il proprio metodo; se un devoto-aparabhakta invece osserva la lama di discriminazione e distacco dello jñånin, si spaventa: come può quello pensare di sezionare la sua adorata noce di cocco? Come può toccarla in maniera così rude, senza pujå, senza adorazione? Come può un uomo assalire così l’Ideale divino, il Sé? Tale essere deve essere certamente un miscredente. Se poi invece il devoto-aparabhakta osserva l’asparsin ritiene che questi sia totalmente folle, addirittura è convinto di essere la noce! Il devoto-aparabhakta afferma: “Questa è la noce, come puoi anche tu essere la stessa noce se ti vedo separato da essa?” Lo jñānin normalmente dovrebbe comprendere che ogni sistema, che alla fine aprirà la noce, è comunque valido; ma, se quella che lui chiama ricerca è un semplice subire le proiezione della propria mente empirica, cercherà di ricondurre gli altri due all’ordine e, visto che sono troppo “stupidi” per comprendere e perdono tempo dietro orpelli e materialità, deciderà di guidarli lui stesso, mostrando come va aperta la noce di cocco! Come vedete, se ci si identifica col proprio metodo, si rischia di non aprire la propria noce, impegnati come saremo nel criticare gli altri, dove troveremo il tempo per aprire la dolce noce?
D - Come metafora è piacevole, ma cosa fa l’advaitin?
R - Beatamente mangia la noce di cocco.
D - Questo agire non è profondamente egoistico? Potrebbe aiutare gli altri ad aprire il guscio della loro noce!
R - Quale guscio? Quale scorza? Dovrebbe convincerli che la buccia che loro toccano e cercano di rompere non esiste? Lo prenderebbero per pazzo perché negherebbe quella che per loro è una verità sostanziale e ineluttabile. Lui è la stessa noce che loro cercano di aprire e “sa” che alla fine con quel metodo l’apriranno, visto che non esiste alcuna noce. Agli altri, a coloro a cui la noce non interessa, cosa dovrebbe fare, tirargliela in testa? Ci pensa già la vita stessa. Affinché un advaitin possa mostrare ciò, un discepolo non deve andare lì dicendo: “Ecco qui la mia noce, aprimela”. Occorre un discepolo che dica: “Eccomi, questi occhi vedono una noce che non c’è, insegnami a vedere la polpa che sono e non il guscio”.
Tratto da: Premadharma, Dialogo dIstruzione, Edizioni I Pitagorici - http://www.pitagorici.it - Tutti i diritti sono riservati. Questo testo può essere riprodotto non a scopo commerciale, senza alcuna modifica e nella sua interezza, includendo queste notizie sul Copyright.
Advaita è una parola sanscrita che significa, letteralmente, “non due”. Sinonimi di Advaita sono non-dualità (nondualità, non dualità). L'Advaita non è né una filosofia né una religione. La non-dualità è uníesperienza nella quale non c'è separazione fra soggetto ed oggetto; un “me” ed il resto dell'universo; un “me” e Dio. E' l'esperienza della coscienza, nostra vera natura, che rivela sé stessa quale assoluta felicità, amore e bellezza. E' chiamata coscienza quella cosa, qualunque essa sia, che è consapevole di queste parole proprio qui, proprio ora.
Un saggio è chi vive in quanto coscienza, essendone consapevole. Dal momento che la consapevolezza è impersonale ed universale, c'è un solo saggio oltre le apparenti distinzioni di razza, genere, età, etc. Un saggio non è necessariamente un insegnante spirituale ed un insegnante spirituale non è necessariamente un saggio.
Ramana Maharshi, Krishna Menon e JeanKlein erano dei saggi che hanno insegnato nel ventesimo secolo. Ramana Maharshi ha usato il metodo dell'auto ricerca con i suoi discepoli meno avanzati. Lo studente che pratica líauto ricerca mantiene la sua attenzione focalizzata sulla sorgente dell'Io-pensieri e dell'Io-sentimenti, ogniqualvolta questi sorgano. Una volta che l'illuminazione ha avuto luogo, il processo dell'auto ricerca continua senza sforzo. L'attenzione spontaneamente ritorna alla sorgente alla fine di ogni pensiero e sentimento e non c'è più bisogno di focalizzare ancora l'attenzione. Studenti più avanzati possono essere portati direttamente all'esperienza del loro vero sé ascoltando la verità dalle labbra del guru e/o attraverso la sua silenziosa presenza. Questo viene chiamato sentierodiretto, il sentiero usato, fra gli altri, da Ramana Maharshi, Krishna Menon e Jean Klein. Il processo dell'autorealizzazione continua spontaneamente fino a quando il corpo-mente-mondo fermamente dimora nella pace e nella felicità. Tutto ciò che può essere detto sull'esperienza della non dualità è, per bene che vada, una pallida approssimazione a livello concettuale, un mero indicatore. Il Buddismo Zen usa la metafora di un dito che indica la luna: anche se il dito indica la luna, il dito e la luna appartengono a due mondi diversi.
L'Advaita trascende tutte le religioni, le filosofie e le nazionalità. Non divide, piuttosto unisce. Membri fanatici di diverse religioni non possono mai accordarsi sui loro concetti di Dio, ma saggi con differenti bagagli culturali non potranno mai non essere d'accordo sulla loro esperienza condivisa della non dualità. I fondatori di tutte le grandi religioni erano dei saggi.
La nondualità è al centro dell'Induismo, del Sufismo, del Buddismo Zen, dello Shivaismo Kashmiro e degli insegnamenti di Cristo:
Induismo: “ Quello che non è ( gli oggetti come separati dal Sé) non viene mai ad essere e ciò che è (il Sé) mai smette di essere”. (Bhaghavad Gita)
Induismo, Shivaismo Kashmiro: Oh meraviglia! Questa illusione, anche se espressa nella molteplicità, non è altro che coscienza-senza-un secondo. Ah, tutto non è che pura essenza consapevole di sé stessa.” (Abhinnavagupta)
Sufismo: “Non esiste nulla che non sia Dio.”
Buddismo Zen: “Domanda: quando un suono cessa, anche la consapevolezza cessa?
Risposta: la consapevolezza non cessa mai” (HuiHai)
Induismo, Shivaismo Kashmiro: “L'universo si sveglia quando tu ti svegli e svanisce quando tu ti ritiri. Quindi la totalità dell'esistenza e della non-esistenza è una con te.” (Abhinavagupta)
Cristianesimo: “ Gesù disse: l'“io” è la luce (della consapevolezza) che brilla sopra ogni cosa. L'“io” è il Tutto dal quale ogni cosa sorge ed al quale ogni cosa ritorna.” (Tommaso, 186)
L'illuminazione è líimprovviso riconoscimento che la non-dualità è, è sempre stata e sempre sarà la realtà della nostra esperienza. La dualità è un'illusione. La coscienza non è né privata né personale, ma è impersonale, universale ed eterna. Non c'è un'entità personale e limitata, non c'è un ego conscio. L'ego è un oggetto percepito, non la consapevolezza che tutto percepisce.
La realizzazione del sé è la successiva stabilizzazione nella pace, felicità e libertà del nostro stato naturale. Il mondo, visto nella luce della consapevolezza impersonale, rivela sé stesso come un miracolo permanente, un dispiegamento divino che celebra la sua invisibile sorgente.
Un guru (insegnante spirituale) vivente è, nella maggior parte dei casi, necessario per facilitare sia l'illuminazione che la realizzazione del sé.
Quantunque il karana guru (il guru il cui ruolo è quello di aiutare il discepolo attraverso gli ultimi stadi della realizzazione) appaia al discepolo come un essere umano apparentemente separato, egli o ella è, consapevolmente, stabilizzato come coscienza universale. Egli vede il discepolo come il suo stesso Sé. La coscienza nel discepolo, essendo riconosciuta per quello che davvero è, risuona con la presenza silenziosa del guru. La mente del discepolo diviene gradualmente e misteriosamente quieta, con o senza l'uso di parole, fino a quando lo studente ha una visione della gioia senza causa del suo stato naturale. Una relazione d'amore, libertà ed amicizia che conduce alla stabilizzazione spontanea e finale del discepolo nella felicità e la pace viene stabilizzata.
Un vero karana guru non vede mai sé stesso superiore o inferiore a nessuno, né prende sé stesso/ sé stessa o nessun altro per saggio o per ignorante, per maestro spirituale o per discepolo. Questo atteggiamento impersonale crea un inconfondibile profumo di amicizia e libertà che è un prerequisito per il successo degli stadi finali del processo di auto realizzazione.
copyright 2000, Francis Lucille
